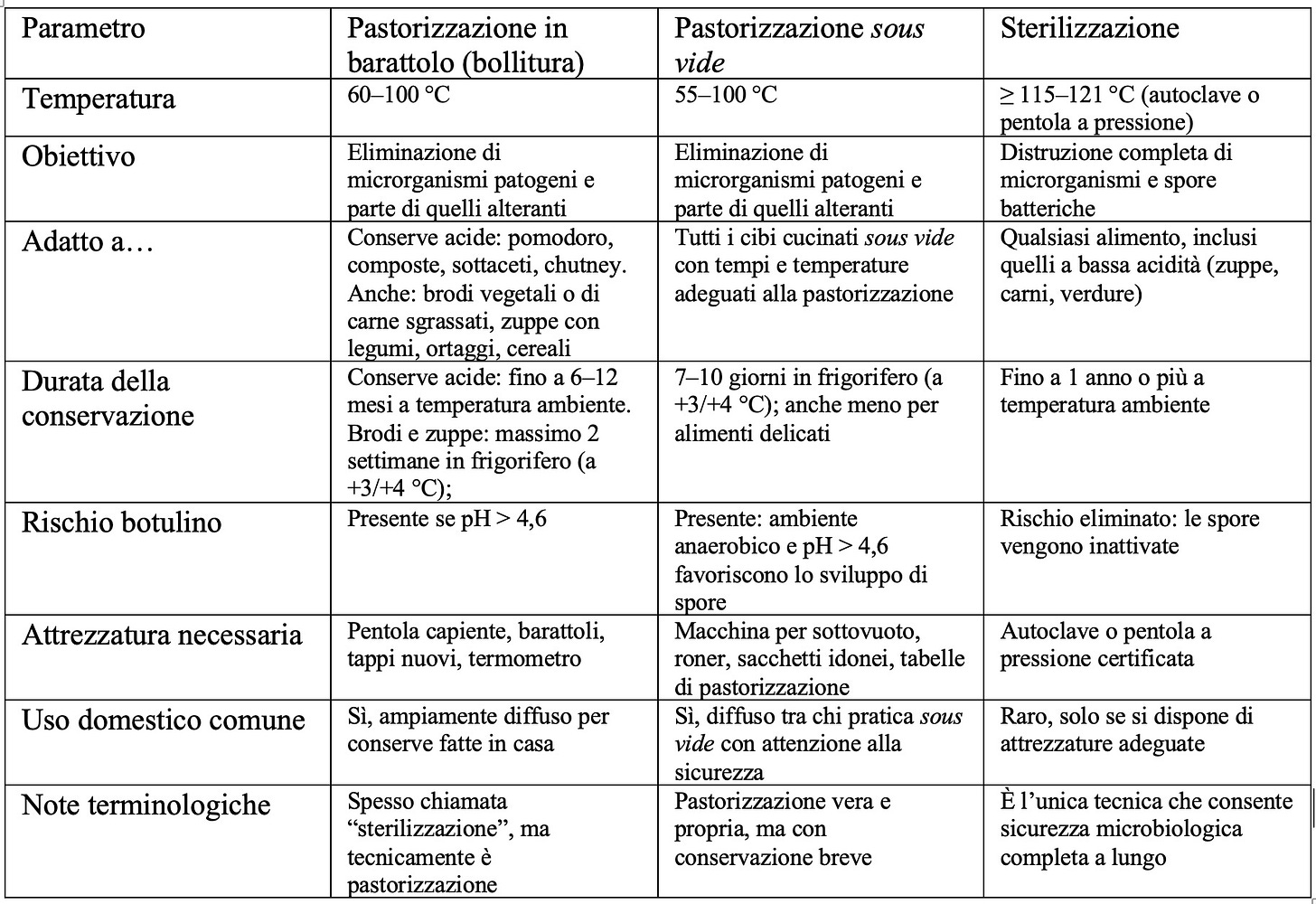Benvenuti al numero 264 di Orazio Food Experience. Un particolare benvenuto a chi si è iscritto nell’ultima settimana! Avverto che questo è l’ultimo post prima di prendermi una piccola vacanza nella settimana centrale di agosto (domenica 17 agosto tra l’altro è anche il mio compleanno). Questo vuol dire che il prossimo numero uscirà il 24 agosto. E’ sempre a vostra disposizione l’archivio dei video su YouTube.
Mangiare è uno degli atti più naturali dell’essere umano: nutre, conforta, scandisce il tempo e costruisce relazioni. Ma se il cibo è presenza, anche la sua assenza, ovvero il digiuno, parla — e spesso più forte. In ogni epoca e in ogni cultura, il digiuno – quando il digiuno è una scelta – ha assunto significati che vanno ben oltre il semplice gesto fisico: può essere offerta, protesta, purificazione, controllo, stile di vita, promessa di benessere, fede. La mia personale esperienza parte dal digiuno come punizione: “vai a letto senza cena” –non so se qualche genitore lo dice ancora – per arrivare alla protesta: mettere il muso e non mangiare, vista l’importanza che i miei genitori davano ai pasti in famiglia, era uno dei modi per fare un capriccio con buona probabilità di essere ascoltato. C’era anche il non mangiare carne il venerdì e poi in età adulta sono arrivate le diete, fino al digiuno totale (qualche anno fa ho fatto 10 giorni di digiuno assoluto, sotto controllo medico, in una costosissima struttura sul lato tedesco del lago di Costanza) seguito da quello intermittente, senza contare i periodi in cui mi sono privato di qualche cibo (pane, zucchero, sale, salumi, latte, pasta; mai il vino…). Dal digiuno rituale del Ramadan alle astinenze del Venerdì Santo, dal detox post-festivo allo sciopero della fame come atto politico estremo, l’astensione dal cibo è un gesto che interroga il nostro rapporto con il corpo, con il desiderio, con l’autorità e con il sacro. Per uno come me che si occupa di cibo, il digiuno ha un fascino sinistro. In questo post mi ripropongo di esplorare il digiuno come fenomeno culturale e antropologico, attraversando religioni, ideologie e mode contemporanee. A volte un buon modo per capire il cibo è osservare cosa accade quando viene tolto dal piatto.
Il digiuno come pratica religiosa
Da millenni, il digiuno accompagna la dimensione spirituale dell’uomo. Presente in tutte le grandi religioni, non è solo astensione dal cibo, ma un atto di disciplina, purificazione e connessione con il divino. Rinunciare al nutrimento quotidiano diventa un modo per ricordare i limiti del corpo, rafforzare la volontà e concentrare l’attenzione su ciò che trascende il mondo materiale.
Nell’Islam, il digiuno trova la sua espressione più nota nel Ramadan, il nono mese del calendario lunare. Dall’alba al tramonto, i fedeli si astengono non solo da cibo e bevande, ma anche da fumo, sesso e comportamenti considerati impuri. È una prova di fede e autocontrollo, ma anche un invito alla solidarietà e alla riflessione. Ogni sera, l’iftar, il pasto che interrompe il digiuno, è un momento conviviale e spirituale.
Nel Cristianesimo, il digiuno ha assunto nel tempo forme diverse. Nell’antichità cristiana era praticato con rigore, in particolare durante la Quaresima, i quaranta giorni che precedono la Pasqua, che ricorda il digiuno di Gesù per quaranta giorni nel deserto, e nei venerdì di penitenza, come il Venerdì Santo. L’astinenza da carne e il digiuno erano espressioni di pentimento, imitazione di Cristo e preparazione alla resurrezione. Oggi, nella maggior parte del mondo cattolico, queste pratiche sono state ammorbidite, ma resistono come gesti simbolici di moderazione e raccoglimento.
Anche nell’Ebraismo il digiuno è carico di significato. Il più importante è Yom Kippur, il giorno dell’espiazione, in cui gli ebrei si astengono da cibo, acqua e ogni forma di conforto per 25 ore. È un tempo di preghiera intensa, perdono e riconciliazione. Altri digiuni minori segnano momenti di lutto o memoria collettiva.
Nel Buddhismo, il digiuno non è sempre prescritto, ma viene spesso praticato dai monaci come forma di distacco dai desideri terreni. Mangiare solo in certi orari, o rinunciare del tutto al cibo in giorni specifici, è un mezzo per liberare la mente e rafforzare la disciplina interiore.
Persino l’Induismo, con la sua pluralità di tradizioni, prevede frequenti astinenze rituali, legate al calendario religioso o a particolari divinità, come il digiuno di Ekadashi, che si osserva due volte al mese, durante le fasi lunari.
In tutte queste pratiche, il digiuno non è una mortificazione fine a sé stessa, ma un modo per “fare spazio”: al sacro, alla preghiera, all’ascolto. Un vuoto fisico che si carica di significati morali e spirituali, e che invita a guardarsi dentro.
Il digiuno come gesto politico
Se il digiuno religioso si rivolge al sacro, quello politico si rivolge al potere. Rinunciare al cibo può diventare una forma estrema di protesta, un atto di resistenza non violenta che trasforma il corpo in campo di battaglia e la fame in strumento di denuncia. Il caso più celebre è probabilmente quello di Mahatma Gandhi, che fece del digiuno un’arma simbolica nella sua lotta per l’indipendenza dell’India. I suoi “satyagraha” – letteralmente “insistenza per la verità” – erano atti di pressione morale rivolti sia al governo britannico sia alla propria comunità. Digiunare significava purificarsi, ma anche mettere gli altri di fronte alla propria coscienza. Nel corso del Novecento, il digiuno è stato adottato da numerosi attivisti per richiamare l’attenzione su ingiustizie e abusi. Le suffragette inglesi agli inizi del secolo rifiutavano il cibo in carcere, sfidando un sistema che le trattava da criminali. La risposta delle autorità fu spesso brutale, con alimentazione forzata e repressione fisica. Nel Nord Irlanda, nel 1981, Bobby Sands e altri militanti dell’IRA morirono dopo lunghi scioperi della fame in prigione per ottenere il riconoscimento dello status di prigionieri politici. La loro scelta, tragica e consapevole, ebbe un enorme impatto mediatico e politico, suscitando reazioni in tutto il mondo. Anche più recentemente, il digiuno è stato usato da dissidenti, intellettuali, monaci e attivisti in vari contesti: dalle carceri turche a Guantánamo, dalle proteste ambientaliste alle battaglie per i diritti civili (ricordate Marco Pannella?). Non sempre il gesto riceve ascolto, ma il suo potere simbolico rimane intatto: chi digiuna mette in gioco sé stesso, sposta il discorso sul piano della vulnerabilità e rende visibile ciò che altri preferirebbero ignorare. Il corpo che rifiuta il cibo è un corpo che dice “no” in modo radicale. Non urla, non aggredisce, non si impone con la forza, ma mette l’avversario di fronte a una scelta etica. È una forma di lotta che ha a che fare con il limite: fisico, morale, politico.
Digiuno e benessere: il mito del detox
Non mangiare per purificarsi: un’idea antica, che però negli ultimi anni ha cambiato abito. Non più saio e cilicio, ma tappetino da yoga, bottiglia termica con infuso di zenzero e – se proprio proprio – un centrifugato al giorno. Il digiuno oggi non è più (solo) una pratica spirituale o politica: è soprattutto una forma di benessere performativo, l’ultima tappa del nostro rapporto complicato con il cibo, il corpo e il controllo. Il mantra è sempre quello: “detox”. Parola magica, che promette di liberarti da tossine, gonfiori, sensi di colpa e pure da un paio di chili (che non guasta mai). Chi ha inventato la parola doveva essere un genio: OK no, solo un esperto di marketing. Perché poi nessuno ha mai visto queste tossine, ma tutti siamo convinti di averle dentro. Le sentiamo. Pesano. Sono quel pasto in più, quel panino in autogrill, quel bicchiere di vino, quella pizza, quel tortino di cioccolato al ristorante che “era piccolo sì, ma non può non aver fatto danni”. E così via con tisane, giorni a base di soli brodi, digiuni intermittenti che cominciano con una cena alle 18:30 e finiscono con un’ansia da frigorifero il giorno dopo. Qualcuno tiene anche un diario: “Giorno 3 senza caffè. Farà male anche il suo profumo?.” Oppure: “Giorno 50 senza pane: mi sento leggero, ma anche un po’ pirla.” Lo abbiamo fatto (quasi) tutti. Io di sicuro. E confesso che la sensazione di controllo è potente, quasi quanto la voglia di pizza che ti prende al tramonto. Il bello è che hai la sensazione che funzioni, o almeno così pare: ci si sente più lucidi, la pancia si sgonfia, l’umore migliora (per poche ore, ma non importa). È una droga sociale soft, anzi, chic. Un argomento da brunch con amici: “Hai provato il reset di 48 ore con acqua di cocco e tè matcha?” “No, ma ho fatto quello da 72 con brodo d’ossa. Rivoluzionario.” Peccato che, dal punto di vista medico-scientifico, la faccenda sia un po’ più opaca. Il corpo umano ha già i suoi sistemi di detossificazione (grazie fegato, grazie reni), e nessuna ricerca seria ha mai dimostrato che smettere di mangiare per un po’ ripulisca davvero l’organismo. Ma che importa? Il detox è una liturgia, non una terapia. Ha i suoi riti, i suoi oggetti di culto (estrattori, infusori, app di digiuno intermittente con badge motivazionali) e soprattutto la sua morale: se mangi, sbagli. Se salti i pasti, sei forte, pulito, superiore. Alla fine il rischio è sempre lo stesso: confondere il benessere con la punizione. Il piacere con il peccato. Il cibo con un problema. E noi stessi con un progetto da ottimizzare. Il detox, insomma, è l’ennesima dimostrazione che più cerchiamo di semplificare la nostra dieta, più finiamo per complicare il nostro rapporto con il cibo. La verità? Per sentirci meglio, forse dovremmo mangiare con meno sensi di colpa, dormire un po’ di più, smettere di misurare tutto, e ogni tanto concederci un piccolo sgarro senza chiamarlo trasgressione. Perché il vero detox, a pensarci bene, potrebbe essere proprio smettere di fare il detox.
Tabù alimentari e la rinuncia come ideologia
Non tutto ciò che evitiamo di mangiare nasce da una prescrizione religiosa o da un programma detox improvvisato. Esistono rinunce più sottili, interiorizzate, che si travestono da scelte personali ma rispondono a logiche culturali o ideologiche. I tabù alimentari non sono solo quelli arcaici o tribali (il maiale per gli ebrei osservanti, il manzo per gli induisti), ma vivono in forma aggiornata anche sulle nostre tavole contemporanee. Oggi, in molti ambienti, il cibo non è più solo nutrimento o piacere, ma una dichiarazione identitaria. Non mangiare qualcosa — carne, glutine, zucchero, latticini, lievito, solanacee, “infiammanti” — può essere un modo per segnalare appartenenza a una visione del mondo. Il piatto diventa manifesto. “Io non mangio” è spesso più potente di “io mangio”: più puro, più radicale, più visibile. C’è chi rifiuta il cibo industriale per ragioni ambientali, chi rinuncia alla carne per etica, chi non mangia glutine pur non essendo celiaco, e chi sfoglia ogni menù come fosse un quiz a eliminazione multipla. Il risultato è che si mangia in difesa, con lo sguardo all’etichetta più che al piatto, in un clima che trasforma la tavola in terreno di sorveglianza alimentare. Ma c’è anche un certo piacere, segreto o dichiarato, nella rinuncia. L’idea che togliere qualcosa ci renda migliori, più forti, più spirituali. È un’idea antica quanto la penitenza: oggi ha solo cambiato lessico. Non si parla più di peccato, ma di tossine, non più di salvezza, ma di longevità. La tavola, da spazio di condivisione e piacere, rischia così di diventare un campo minato, dove ogni ingrediente è sospetto e ogni boccone è accompagnato da una postilla. E in tutto questo, paradossalmente, si finisce per parlare di cibo più di quanto lo si gusti.
Alla fine, che si tratti di un gesto di fede o di una moda passeggera, privarsi di qualcosa resta un modo (a volte nobile, a volte comico) per riscoprirsi diversi — o almeno più leggeri, sulla bilancia o nell’anima. Buona domenica!
Se ti è piaciuto questo post, fammelo sapere usando il cuoricino per i like!
Un consiglio per gli acquisti: il mio libro “La mia cucina a bassa temperatura sottovuoto” e si trova su Amazon in versione cartacea oppure digitale. Buona lettura!
Questo numero contiene:
La videoricetta: Fusilli con crema di melanzane
Il ristorante della settimana: Tragabuches, Marbella (Spagna)
Il vino della settimana: Frankfurt International Wine Trophy
Se volete farmi un regalo di compleanno, inoltrate questa newsletter a uno o più amici buongustai e convinceteli a iscriversi. Qui il bottone per condividere:
Se vi occorre qualcuno degli attrezzi di cucina che uso nelle videoricette, trovate i link ad Amazon nella descrizione dei video sulla pagina YouTube (cliccate “Mostra altro”, perché la lista sta in fondo), o, in mancanza, troverete comunque il modello dell’attrezzo utilizzato. Acquistare da questi link è un modo per sostenere il lavoro che sta dietro ai video.
La videoricetta: Fusilli con crema di melanzane
Pochi ingredienti, un sapore intenso e una consistenza avvolgente. I fusilli con crema di melanzane sono un primo piatto mediterraneo che unisce semplicità e gusto. La crema di melanzane, un vero jolly in cucina, facile da preparare anche il giorno prima, è la base vellutata su cui si innestano la freschezza dei pomodorini saltati e la sapidità della ricotta salata grattugiata. Un piatto colorato e profumato, perfetto per un pranzo estivo senza stress ma con tutto il sapore della cucina di casa. Buona visione!
Il ristorante della settimana: Tragabuches, Marbella (Spagna)
Qualche tempo fa vi ho parlato dell’elegante Leña, la cucina alla brace del Gruppo Dani Garcia; questa volta invece sono stato da Tragabuches, la “venta” (taverna) andalusa moderna dello chef. Siamo a Marbella, in Calle Ana de Austria, 2, in un luogo tranquillo, lontani dall’affollato lungomare. L’interno è accogliente, con un design essenziale e raffinato, luminoso, spazi ampi, materiali caldi e un grande banco centrale che espone frutta e verdura, insieme a una serie di jamones pronti per essere affettati ovviamente a mano. L’arredo è minimalista ma accogliente in un’atmosfera tra familiare e conviviale. Anche questo Tragabuches, come il primo aperto nel 1998 nella storica città di Ronda, continua nella originaria missione di celebrare e onorare l’essenza dell’Andalusia attraverso una cucina radicata negli ingredienti locali. La proposta gastronomica valorizza infatti ricette locali della tradizione andalusa rivisitate con eleganza e semplicità in un contesto che celebra territorio e tradizione. Si passa dai bocconi conviviali ai comfort food rivisitati, dalla Ensaladilla rusa con maionese cremosa e jamón ibérico, al Calamar frito en anillas y alioli de adobo (anelli di calamari fritti serviti con salsa aioli) fino alla Tortilla de patata con cebolla trufada (tortilla servita con salsa di cipolla tartufata) e le classiche Croquetas de jamón ibérico. Il menu offre una buona selezione di pesci e carni alla griglia. Rispetto al menù ufficiale, non si può non farsi rapire dalla lunga lista di piatti del giorno, presentati su una lavagnetta (conviene fare una foto e guardarseli con calma se non si vuole che il cameiriere stia lì una vita con la lavagna ad aspettare). Li avrei presi tutti, ma alla fine mi sono limitato ai Calamaretti alla galiziana e alla Vetresca di bonito (tonnetto alalunga) alla brace, lasciando per la prossima volta lo Scorfano di Conil fritto e i Fiori di zucchina ripieni di cozze. Servizio attento e curato in un’atmosfera rilassata e cantina ben fornita con vini da tutta la Spagna, ma anche dall’estero. Veramente un buon posto appena al di fuori della movida di Marbella. Da prenotare con anticipo. Tragabuches
Il vino della settimana: Frankfurt International Wine Trophy
Il Frankfurt International Wine Trophy è un concorso enologico internazionale che si tiene ogni anno a Francoforte (Germania) e riunisce una giuria mista di esperti – enologi, sommelier, giornalisti – insieme a consumatori appassionati. L’evento valuta vini provenienti da tutto il mondo, assegnando medaglie basate su criteri di qualità, tipicità e piacevolezza. È uno dei pochi concorsi a coinvolgere degustatori professionisti e non professionisti nello stesso panel, con l’obiettivo di premiare vini che sappiano convincere sia il mercato sia la critica. I produttori o distributori iscrivono i vini e inviano bottiglie in quantità e formato richiesti dall’organizzazione (quest’anno oltre 2500 provenienti da tutto il mondo). I vini vengono distribuiti su diversi tavoli e in ogni tavolo c’è una giuria composta sia da professionisti (enologi, sommelier, giornalisti del vino) sia da appassionati selezionati, così da combinare rigore tecnico e percezione del consumatore. Ogni vino viene assaggiato alla cieca, senza che i degustatori conoscano l’etichetta, il produttore o il prezzo, per evitare condizionamenti. Ogni membro della giuria esprime valutazioni su una scheda in cui si valutano i parametri tipici nella degustazione di un vino come vista, olfatto, gusto, equilibrio, tipicità, armonia complessiva e si esprime un punteggio in centesimi. Solo i vini che superano determinate soglie di punteggio ricevono riconoscimenti. Molto interessante notare che tra i vini premiati, e quindi che hanno ricevuto valutazioni elevate, ce ne sono numerosi con prezzi decisamente molto bassi. Angelo Sabbadin anche nell’edizione 2025 è stato invitato come giudice esperto e da questa esperienza ha tratto un bell’articolo pubblicato nella sezione vino di Passione Gourmet mostrandoci i vini che a lui sono piaciuti e che hanno ricevuto valutazioni elevate, mostrandoci anche i loro prezzi. Ecco il link all’articolo: Frankfurt International Wine Trophy.
Buona lettura, buona domenica e buon Ferragosto!
* * *
Questa newsletter è gratuita, ma se volete offrirmi uno dei caffè che consumo per scriverla potete farlo via PayPal, usando questo link Orazio Food Experience su PayPal e selezionando “invia denaro ad amici”.
Per fare la stessa cosa via Satispay, ecco il QR Code da inquadrare.